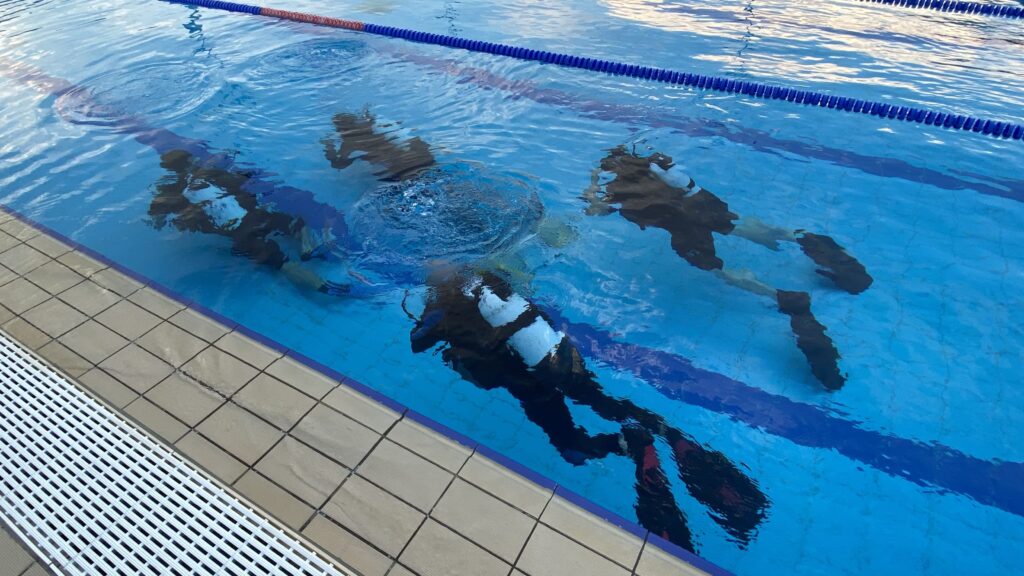Lo scorso weekend il Centro Sub Treviso ha organizzato un’uscita subacquea a Selce, splendida località della Croazia affacciata sul mare...
Leggi di piùIl nostro blog
Il Processo aea Vecia: una tradizione trevigiana che torna a illuminare il Sile
Anche quest’anno, il Centro Sub Treviso parteciperà con orgoglio alla tradizionale festa del Processo aea Vecia, uno degli eventi più...
Leggi di più10 Motivi per Iniziare a Fare Subacquea
10 Motivi per Iniziare a Fare Subacquea Scopri i Corsi del Centro Sub Treviso Il Centro Sub Treviso offre corsi...
Leggi di piùBrevetti Sub 1 Livello: La Tua Porta d’Ingresso al Mondo Sottomarino
Esplorare i fondali marini è un’esperienza unica, e il primo passo per entrare nel mondo della subacquea è conseguire i...
Leggi di piùImmersione al Relitto del Pasubio in Calabria: Storia, Avventura e Biodiversità
Il Relitto del Pasubio, situato al largo di Roccella Jonica in Calabria, rappresenta una delle immersioni più affascinanti per gli...
Leggi di piùAlla Scoperta dei Relitti Sottomarini: Fascino, Sfide e Biodiversità
L’esplorazione dei relitti sottomarini è una delle esperienze più affascinanti e avventurose che il mondo subacqueo possa offrire. Questi monumenti...
Leggi di piùIl controllo dell’assetto subacqueo: come restare neutrali in acqua
Il controllo dell’assetto è uno degli aspetti fondamentali per ogni subacqueo, a prescindere dal livello di esperienza. Avere un buon...
Leggi di piùCompensazione nella subacquea
La compensazione è una tecnica fondamentale nella subacquea che consente di equilibrare la pressione tra l’ambiente esterno e gli spazi...
Leggi di piùRelitto dell’El Hawi Star
Se sei un appassionato di immersioni e desideri esplorare relitti affascinanti, il Centro Sub Treviso ti invita a unirti a...
Leggi di piùPartenza dei corsi tecnici subacquei
Il Centro Sub Treviso offre una vasta gamma di corsi tecnici per subacquei che vogliono superare i limiti dell’immersione ricreativa...
Leggi di piùConclusi i corsi di specialità “Muta Stagna” e “Immersione Notturna/Visibilità limitata”
Si sono conclusi i corsi di specialità organizzati dal Centro Sub Treviso sull’uso della Muta Stagna e la condotta di...
Leggi di piùCorsi Subacquea per Principianti a Treviso
Scopri il meraviglioso mondo della subacquea con i corsi Subacquea per principianti offerti dal Centro Sub Treviso. Se sei alla...
Leggi di piùDifferenza tra Corsi Tecnici e Ricreativi
Nel mondo della subacquea, esistono due principali categorie di corsi: tecnici e ricreativi. Entrambi offrono esperienze uniche e formative, ma...
Leggi di piùImmersione a krk
L’isola di Krk, nel cuore del Mar Adriatico, è una delle destinazioni più affascinanti per gli appassionati di immersioni subacquee....
Leggi di piùOgni studente è un viaggio personale
Il Centro Sub Treviso non è solo una scuola di immersioni, ma piuttosto un rifugio per coloro che desiderano vivere...
Leggi di piùL’Espansione delle opportunità subacquee: le immersioni tecniche
Recentemente, abbiamo avuto l’onore di ospitare un’autorità di rilievo nel campo della subacquea ricreativa e tecnica, Gabriele Paparo. Gabriele non...
Leggi di piùESPLORARE LE PROFONDITÀ CON LA MASSIMA SICUREZZA: LA BATTAGLIA CONTRO L’ANIDRIDE CARBONICA
La subacquea è un’esperienza straordinaria che offre emozioni uniche e la possibilità di esplorare mondi sottomarini mozzafiato. Tuttavia, così come...
Leggi di piùScuola di Subacquea della Provincia di Treviso: Un’Immersione nella Didattica NADD
La subacquea è un’esperienza affascinante e coinvolgente, e il Centro Sub Treviso è il luogo ideale per avvicinarsi a questo...
Leggi di piùQuali sono i Brevetti della subacquea?
Cari appassionati del mare e avventurieri subacquei, presso il Centro Sub Treviso, ti offriamo un’opportunità straordinaria di esplorare le profondità...
Leggi di piùQual è il momento ideale per fare un corso di subacquea?
Appassionati del mondo subacqueo e curiosi esploratori del mare ti sei mai chiesto qual è il momento ideale per intraprendere...
Leggi di piùMantieni la Tua Attrezzatura Subacquea in Perfetto Stato: Consigli per la Pulizia e la Manutenzione
L’attrezzatura subacquea è il tuo compagno nel mondo subacqueo, e mantenerla in ottime condizioni è essenziale per garantire immersioni sicure...
Leggi di più